GREEN DAY: THE ORIGINAL MOTHERF*****S

Sembra impossibile che i Green Day siano sul punto di passare i 33 anni di attività. Un po’ per l’attitudine da eterni Peter Pan di Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt, un po’ per la capacità del gruppo di porsi sempre con vesti diverse, fatto sta che la band californiana è arrivata al 2019 in buona salute. Certo negli anni sono mancate le cadute di stile, e nemmeno degli album poco convincenti, ma tutto è parte del gioco, perché in fin dei conti la cosa più importante è sempre quella di rialzarsi e rimettersi in pista. In questo i Green Day, con Armstrong come campione, sono dei veri e propri dottori, e proprio quest’anno pare che siamo sul punto di assistere ad una nuova trasformazione del gruppo.
33 anni di carriera, 25esimo...
l'articolo continua...
anniversario di Dookie, non c’era anno migliore per Armstrong e soci per annunciare l’arrivo di un nuovo album ed infatti Father Of All Motherfuckers, arriverà il 7 febbraio 2020 su Reprise Records. La notizia ha movimentato il mondo musicale, e ad aggiungere un ulteriore grado di eccitazione è arrivata anche la conferma di un tour mondiale in compagnia di nientemeno che Weezer e Fall Out Boy… E gli anni ’90 trionfarono nuovamente.
Scherzi a parte, proprio quando il globo riscopre la gioia di cantare Basket Case a squarciagola, non si potrebbe trovare un momento più adatto per tornare a guardare alla spericolata storia del trio e del perché la sua entrata in gioco sul finire degli anni ‘80/ inizio ‘90 rappresenta un momento catartico per la scena musicale mondiale.
………………………………………………………………………………………………… .
GREEN DAY lineup 2019
Billie Joe Armstrong (vocals, guitar) – Mike Dirnt (bass) – Tré Cool (drums) – Jason White (touring guitarist)
……………………………………………………………………………… .………………..
THE EARLY DAYS
La storia è nota, ma è il contesto che ci interessa. Armstrong e Dirnt si conoscono fin dai tempi delle elementari, ed il loro amore per Ramones e Dead Kennedys è ciò che basta per accendere quella scintilla che pochi anni dopo darà vita ai prodromi dei Green Day. È il 1996 e la prima incarnazione del gruppo si chiama Sweet Children, formati da Armstrong e Dirnt insieme a Sean Hughes (che dura poco all’interno della lineup). Il nome viene cambiato molto presto nel definitivo Green Day, ispirato principalmente da un candido amore per la cannabis, e nel 1989 – quando Armstrong ha soltanto diciassette anni – il mondo conosce il gruppo con la pubblicazione di 39/Smooth sotto l’effige della Lookout Records. Si tratta di un punk veloce e sfacciato, come ricetta vuole, ma già pronto a mostrare la tendenza melodica che diverrà il marchio di fabbrica della band negli anni a venire. Tuttavia manca ancora qualcosa.
Quel qualcosa arriva nel 1991, ufficialmente intitolato Kerplunk (secondo album del gruppo per Lookout Records) ma realmente chiamato Tré Cool. Dopo aver cambiato diversi batteristi la band incontra sulla propria strada nientemeno che Tré Cool, all’anagrafe Frank Edwin Wright III. Quest’ultimo dall’età di dodici anni al servizio della punk band Lookouts, è l’ultimo decisivo tassello necessario al completare il puzzle del gruppo, ormai sul punto di abbandonare le scorribande degli esordi per una formula molto più coesa e adeguatamente confezionata.
Il 1991 è un anno cruciale, per i Green Day ma soprattutto per tutti quei generi musicali nati dalla distorsione, dalla rabbia, dal movimento giovanile e dall’estrema voglia di farsi sentire. Rock, metal, indie, punk, quella corrente ciò che dal finire degli anni ’70 e durante tutti gli anni ’80 aveva animato un movimento in grado di innalzare l’entusiasmo DIY alla stregua di un credo religioso era pronta a lasciare spazio ad una nuova era. Il mondo delle label indipendenti e quel formicaio di intraprendenti senza paura stavano per essere investiti da un uragano.
90ies: INDIE NO MORE
Doveva accadere per forza. Gli anni ’80 avevano consacrato il mondo indipendente a forza motrice del mercato discografico, e proprio per questo - una volta stabilitone il valore - nulla avrebbe fermato le major dal provare a inglobare quanto più possibile di quella estremamente organizzata fetta del music business. Sul principio degli anni ’90 album come i primi due firmati dai Green Day, e pubblicati da indipendenti come la Lookout Records, muovevano una importantissima parte dei profitti del mondo discografico, ormai obbligato a fare i conti anche con un nuovo tipo di pubblico.
Qualcosa di simile era già successo circa vent’anni prima con la cultura hippie, ma quest’ultima aveva impiegato molto meno a conquistare gli scaffali più in vista di negozi di dischi e supermercati. Al movimento iniziato a metà anni settanta da Ramones e Sex Pistols era servito molto più tempo, giusto poco meno di due decadi, e per abbatterlo definitivamente serviva che accadesse qualcosa di inequivocabile.
Nevermind arriva nei negozi di dischi il 24 settembre del 1991 e, molto semplicemente, tutto cambia. L’album porta ai primi posti delle classifiche un mix di elementi presi senza distinzione da band come Dinosaur Jr., Pixies, Black Flag, Fugazi e dozzine di altri nomi, eppure tutto d’un tratto sembra che il mondo non abbia mai sentito nominare nessuna di esse. Inizialmente le mosse promozionali dietro Nevermind sono praticamente nulle, ma niente vieta all’album dei Nirvana di fare tabula rasa conquistando ogni possibile classifica, spazio radiofonico e scaffale.
La scena indipendente aveva sempre vissuto su una comune ed inscalfibile fede nel fatto che la speranza di un successo commerciale era semplicemente utopia. Le cose non sono più così: Nevermind annulla tutto, è un reset completo del sistema. Il risultato finale? Rielaborando le parole di Michael Azerrad (Our Band Could Be Your Life, 2001 Back Bay Books) il limite ultimo si sposta dal tetto del seminterrato al blu sconfinato del cielo. I Nirvana fanno da apripista, e le major scoprono il clamoroso potenziale a disposizione di etichette indipendenti sparse in tutti gli States, molte delle quali più che disposte a vendere il proprio catalogo (se non il proprio nome) per la giusta cifra. Molte vengono schiacciate dalle acquisizioni, altre label invece, come Matador, Merge Records e la stessa Lookout Records, riescono a sfruttare il momento positivo per riuscire finalmente a capitalizzare sugli sforzi di tanti anni. Questo non ferma però le major dal mettere sotto contratto alcune delle band di maggior successo della scena indipendente. Una fra tante? I Green Day.
DOOKIE: L’INIZIO DEL REGNO
39/Smooth e Kerplunk erano stati dei discreti successi underground, e così, nel momento in cui il mercato dimostra di avere spazio per del rock sporco e grezzo anche fra le sfere che contano, i Green Day (e la loro affabilità pop) sono uno dei nomi più appetibili ad emergere dal trambusto post-Nevermind . La band di Armstrong, Tré Cool e Dirnt firma per Reprise, label decisamente più della preparata Lookout a sostenere la mole di lavoro che sarà richiesta per supportare il successo di Dookie . Si tenga a mente che al momento di mettere sotto contratto i Green Day, Reprise era la casa discografica di Stevie Nicks e Neil Young, non certo quella di Superchunk, Pavement o Bad Religion.
Registrato fra il settembre e l’ottobre dell’anno prima, Dookie arriva sugli scaffali nel febbraio del 1994, ed in poco meno di 40 minuti di durata racchiude una manciata di brani che marchiano a fuoco la scena punk così come la scena rock tutta. Un’impertinente ma comunque brillante raccolta di canzoni che parlano di apatia, noia suburbana e crisi esistenziali a metà fra adolescenza e mal accolta età adulta, il tutto condito da una solare e svogliatamente disinteressata attitudine. Lo chiameranno pop-punk, ma nel momento della sua uscita Dookie è considerato soltanto un tradimento. Dopo aver costruito il proprio seguito a suon di performance sudate e febbrili fra i peggiori club a disposizione, il costitutivo animo pop di Dookie sconvolge i punk. Si grida al sacrilegio, fioccano bastonate da ogni dove, e alcuni club fra i più conservatori (e guardate bene all’ironia del termine utilizzato) emettono dei veri e propri bandi di cacciata dei Green Day dai loro palchi. Al grido di “Venduti!” la scena punk sembra voler stabilire la fine della band, ma la verità è che per certi proclami è già troppo tardi. Il punk degli esordi non c’è più, gli stessi punk l’hanno istituzionalizzato e messo sotto una teca, fatta sì di sudore, sputo, punte acuminate e magliette strappate, ma sempre e comunque una teca. Con Dookie i Green Day hanno il coraggio di compiere il passo che tutti i loro commilitoni si vergognerebbero di ammettere di aver sognato possibile: far diventare la musica il proprio lavoro.
Dookie è l’album perfetto nel momento perfetto. Il pubblico ha bisogno di nuovo di divertirsi, ha bisogno di energia, di brani che facciano saltare e dimenarsi, e i nuovi Green Day hanno tutto questo e molto di più. La band ha l’attitudine giusta per risultare tollerabile anche per chi nel 1991 era intento a divorare Metallica , e soprattutto ha la giusta dose di ironia e di strafottenza per cantare i disagi di una nuova generazione ma subito dopo prenderla a calci in culo.
TIME OF YOUR LIFE
Dookie è in assoluto l’album del catalogo Green Day ad aver venduto più, con più di 20 milioni di copie diffuse e con un sound in grado di riportare alla mente un ben preciso momento storico resta ancora oggi l’album più influente mai pubblicato dalla band. Sulle ali del successo ottenuto questa inizia a cavalcare le onde di una fanbase sempre più vasta ed a godere del rispetto (parola deplorevole per ogni vero punkster) dell’establishment.
Nell’ottobre del 1995, sempre per Reprise, esce Insomniac, che non solo sfiora il primo posto in classifica con una seconda posizione nella Billboard 200, ma mette in mostra qualcosa di inatteso, ovvero un songwriting sorprendentemente maturo, oscuro, ed in grado di affrontare tematiche come alienazione ed abuso di droghe con un’inedita vena di sarcasmo. Insomniac sposta anche il sound imposto da Dookie su frontiere leggermente più heavy, passaggio necessario per uscire da quel limbo in cui la band era caduta in seguito al successo riscosso dal precedente lavoro. Le critiche ricevute dall’album del 1994 da parte della ala più purista del punk non lasciano indifferenti Armstrong e compagni, i quali decidono di riscattarsi proprio con Insomniac. L’album non gode praticamente di alcuna promozione, ed il merito di ciò va alle troppe parole da censurare contenute nella gran parte dei testi, in aggiunta il videoclip del brano God Told Me to Skin You Alive viene rimosso da MTV a causa del contenuto troppo spinto (il fulcro del video è un dipendente da metanfetamina intento a farsi rimuovere i denti). L’album non sfiora neanche lontanamente i dati di vendita di Dookie, ma viene accolto a braccia aperte da molta della stampa rock di tutto il mondo, andando quasi ad oscurare chi ancora guardava alla svolta major della band come ad una disgrazia.
Se Insomniac aveva mostrato un lato più dark del gruppo senza però lasciar ben intuire dove l’evoluzione della band potesse portare, ci pensa Nimrod (1997) a mescolare ulteriormente le carte in tavola. Diciotto tracce contenenti accenni di violini, chitarre acustiche, fiati ed elementi che spaziano tra folk, surf e neo-psichedelia. Volevate un cambiamento? Eccovi serviti.
Il quinto album in studio della band colpisce duro nel dare esempio di come Armstrong possa essere un capitano imprevedibile, ma soprattutto mostra a tutti che il gruppo ha definitivamente smesso di prestare attenzione a chi ancora li accusa di aver tradito le proprie origini. C’è un progetto più ampio a guidare il destino di Armstrong e dei compagni, un destino che passa inevitabilmente da una crescita autoriale che proprio con Nimrod pone le basi per quell’American Idiot che di lì a sette anni sarà in grado di far gridare mezzo mondo al miracolo. Guidato dal successo devastante di Good Riddance (Time of Your Life) – ad oggi il singolo più ascoltato della band – Nimrod afferma che ormai la band parte di un mondo ben più vasto di quello che le ha dato i natali.
AMERICAN IDIOT
Finito un tiepido tour di supporto a Nimrod, album apprezzato ma recepito mediamente bene dal pubblico i Armstrong e soci scoprono che nel mondo musicale è avvenuto un nuovo cambiamento e che il numetal guidato da Korn e Limp Bizkit ha conquistato le classifiche rock e metal. Il punk sembra essere passato di moda, e pertanto la band deve decidere dove lanciare la propria proposta. La risposta è Warning, uscito nell’ottobre del 2000 sempre per Reprise, album che ancora oggi divide le opinioni di chi lo reputa il primo vero fiasco del gruppo, e chi invece lo considera un album troppo semplicemente archiviato nell’ombra del successore, American Idiot.
La verità è probabilmente una via di mezzo. In Warning ci sono buone idee, ma è indubbiamente la vena pop ad emergere con prepotenza sopra le distorsioni potenti che soltanto nel precedente Nimrod avevano caratterizzato brani come Platypus, All The Time o The Grouch. È difficile, anche a distanza di tempo, tornare su Warning e provare ad effettuarne una completa rivalutazione, in quanto si tratta probabilmente di un album troppo debole per essere fondamentale, ma comunque abbastanza valido da essere considerato un punto di passaggio obbligatorio per la band.
È il novembre del 2002 ed i master di Cigarettes and Valentines, l’ideale seguito di Warning, vengono misteriosamente fatti sparire. Successivamente si riuscirà a rintracciare il materiale, ma la band decide fin da subito di cominciare nuovamente da zero. Il prodotto si rivela il successo più acclamato e indiscusso della band.
American Idiot contiene in sé l’anima di Warning , alcuni slanci di velocità di Insomniac ed il gusto per i mid-tempo già espresso molto bene con Nimrod . L’album è un successo di scala globale, con ben diciannove paesi in tutto il mondo pronti ad innalzarlo ai primi posti delle classifiche. La sua diretta critica all’amministrazione Bush, così come alla società americana più bigotta ed alla guerra in Iraq, lo rendono un album potente ed in grado di attecchire – paradossalmente – in molte zone del globo. A confermare l’accoglienza riservata all’album ci sono più di 16 milioni di copie vendute, un GRAMMY assegnato alla band per la categoria Best Rock Album e persino un musical tratto dai suoi brani. American Idiot è la consacrazione del trio a superstar, status che trascende generi e mode, e che consegna ad Armstrong la possibilità di osare là dove quel punk quindicenne non avrebbe mai pensato di poter arrivare.
WHERE TO NOW?
La carica infusa dal successo del 2004 si ripercuote sulla band a mo’ di propellente per i cinque anni che seguono la pubblicazione, cinque anni che servono a ricaricare le batterie e a preparare le diciotto tracce che daranno vita ai 70 minuti di 21st Century Breakdown. L’album, strizzando l’occhio al suo predecessore, è una sorta di concept su tema sociale, un lavoro stratificato e forse più elaborato di quanto non fosse American Idiot. Il tema principale questa volta è l’egoismo come filtro della società, la formula sonora è quella di AI, arricchita però dalla riscoperta passione di Armstrong per le ballad al pianoforte.
Dopo il clamore suscitato da American Idiot non sarebbe stato difficile scadere nell’oblio di un nuovo album slavato e semplicemente derivato da qualche idea secondaria ricevuta in eredità dalle session precedenti, ed invece 21st Century Breakdown conferma come i Green Day abbiano finalmente trovato una loro formula, l’abbiano perfezionata, e soprattutto di come abbiano trovato la ricetta perfetta per fregarsene di qualsiasi tipo di etichetta. L’album del 2009 ed il GRAMMY assegnatogli suggellano anche il fatto che il punk non ha più motivo di entrare nella conversazione riguardante i Green Day: alla band piace il pop, piace la distorsione, e sì, piace anche il punk.
21st Century Breakdown è un album ispirato, un lavoro che mette d’accordo molti e che accontenta tanti, e non a caso è l’album che meglio aggredisce le classifiche di tutto il mondo, anche meglio di American Idiot . Per molti è considerato l’ultimo vero buon album della band, il motivo? L’imprevedibilità di Armstrong, ovviamente.
La ricezione di 21st… carica nuovamente i Green Day di ulteriori aspettative, un po’ come se dopo aver raggiunto il primo posto delle chart in un back-to-back pressoché perfetto non fosse già abbastanza. È proprio a quel punto che qualcuno degli addetti ai lavori comincia a far notare come nel turbine di una carriera sfociata in successi così prepotentemente esuberanti, è sembrato che il mondo si dimenticasse di quella tanto fragile quanto conturbante personalità rispondente al nome di Billie Joe Armstrong. Il culmine di critiche pronte a ignorare ogni nota positiva e pressioni prolungatesi fin dai primi anni ’90 arriva il 21 settembre del 2012 sul palco dell’iHeartRadio Festival di Las Vegas. Gli organizzatori del festival si accorgono di essere in ritardo di quasi mezz’ora sulla scaletta del concerto, e così decidono di comunicare ai Green Day – on stage nel bel mezzo di Basket Case – che hanno soltanto un minuto rimanente a disposizione. La scritta “1 minute” compare sul gobbo elettronico e Armstrong dà in escandescenza.
La band avrebbe dovuto presentare in anteprima un brano tratto da ¡Uno!, primo dei tre nuovi album pronti ad essere pubblicati nella trilogia formata con i restanti ¡Dos! e ¡Tré!. Lo sfogo sul palco di Armstrong – completato da chitarra distrutta – fa il giro del web ed oblitera ogni tipo di promozione pianificata da Reprise e Warner per supportare la mastodontica sfida discografica.
¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré! contengono ritornelli ammiccanti e idee che sanno funzionare, ma sulla corsa di ben 37 tracce totali pubblicate nell’arco di sei mesi, tutto suona un po’ ridondante, a tratti annacquato. In molti teorizzano che i tre album avrebbero potuto essere ben ridotti ad un’unica uscita discografica di buon peso, ma Armstrong non ha tempo per ascoltare le voglie del mercato. Credo che questo sia quello che la gente vuole sentire, dice della trilogia, e aggiunge poco altro alle tante domande sollevate dal progetto. Il mercato ed i fan non danno ragione alla band, con ben due dei tre album che non raggiungono nemmeno la stima minima di vendite pronosticata dalla label.
Al gruppo servono quattro anni per sbollire la rabbia e mettere da parte il mezzo fallimento di ¡Uno!, ¡Dos! e ¡Tré!, e nel 2016 Revolution Radio riconsegna dei Green Day che sembrano aver riabbracciato un’unica idea, ovvero quella di tirare fuori un album solido e senza troppi fronzoli. Revolution Radio è proprio questo, un disco onesto, una perfetta fotografia di una band passata dall’essere un trio di punk squattrinati a rock star di livello planetario. Certo a tratti l’album pecca un po’ di boriosità, la voce di Armstrong sembra un po’ più debole di quanto ascoltato in passato, e alcuni brani non sempre riescono a portare a compimento la propria missione, ma in fin dei conti Revolution Radio convince abbastanza da essere considerato un ritorno degno del nome Green Day.
Approdiamo quindi Father Of All Motherfuckers? L’album in uscita a febbraio 2020, già forte di dichiarazioni che vorrebbero Armstrong intento a trasferire nei Green Day la sua immersione nel soul e nella black music, ha subito fatto parlare mezzo mondo. I singoli Father of All… e Fire, Ready, Aim, strizzano l’occhio a sonorità solitamente associate a band come The Hives o The Raconteurs, ma indubbiamente mostrano come il 2020 sarà anche l’anno di una nuova svolta artistica per la band di Armstrong. Se questa svolta sarà portata a compimento con successo o meno è ancora da vedere, ma da quanto ascoltato fino ad ora sembra proprio ci troveremo di fronte ad un album in grado – perlomeno in teoria – di avviare una nuova conversazione, cosa di per sé sempre intrigante. Non resta che attendere quindi, perché se c’è una cosa che i Green Day hanno dimostrato in più di 33 anni di carriera è di non farsi più molti problemi nel momento di intraprendere strade scoscese. Il risultato finale potrebbe essere un disastro? Certo, ma conoscendo i nostri potrebbe anche essere l’ennesimo colpo grosso.
Leggi anche
Podcast
Album del mese
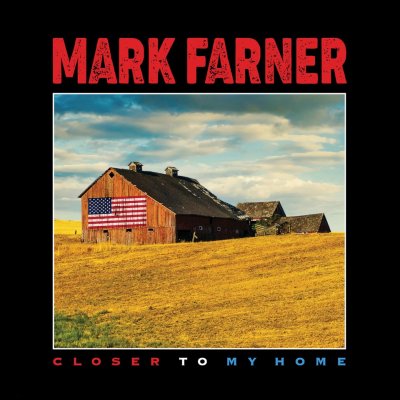
Mark Farner
Closer To My Home
Righteous Rock Records
Se tra gli scaffali di casa vostra campeggiano titoli quali On Time, Grand Funk o E Pluribus Funk potete tranquillamente continuare la lettura: avete tra...

Michael Kiwanuka
Small Changes
Polydor Records
Si parte con "Floating Parade" e si fluttua, tappa dopo tappa, tra la bellezza aerea di "One And Only", il progressivo incedere delle due parti...
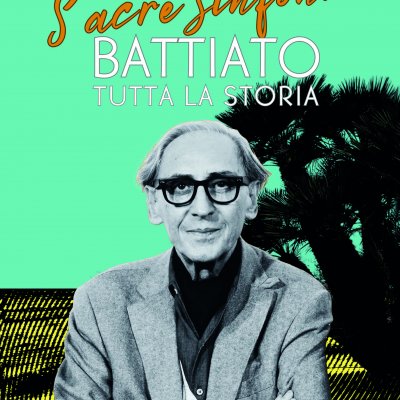
FABIO ZUFFANTI
Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia
Il Castello / Chinaski Edizioni
Nato dalla penna di Fabio Zuffanti, "Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia", è il titolo della più recente e completa biografia dedicata al celebre artista...



