Il mondo di PETE TOWNSHEND: The Who


Newcastle, 5 novembre 1973 – Gli Who sono sul palco, belli carichi per la prima delle tre serate in programma all’Odeon Cinema. Stanno promuovendo Quadrophenia, la loro nuova e grande opera, la più ambiziosa, scritta interamente dal loro visionario leader, Pete Townshend. Ma è un disastro totale. Il pubblico fatica a cogliere la profondità della storia, nonostante Townshend e Daltrey si barcamenino a spiegare la trama, tra un pezzo e l’altro.
La magia non attecchisce all’Odeon, seppellita dalla fatica di capire e farsi capire. E, soprattutto, la fretta della Track Records di spedirli in tour non appena finita la (estenuante) produzione, non aiuta di certo.
La band è sul palco e, quando è il momento...
l'articolo continua...
di attaccare il tarantolato 5:15, non c’è alcun sync con le tracce su nastro; poi si degna di partire, ma con 15 secondi di ritardo. Addio. A Townshend gli si chiude la vena. Si avvicina a grandi passi a Bob Pridden [tecnico del suono con gli Who] lo afferra per il collo e lo scaraventa malamente oltre il banco di missaggio, verso il centro del palco... poi Townshend si libera della sua Gibson lanciandola sul palco e devasta i nastri con le tracce pre-registrate, prima di scomparire rabbioso dietro le quinte. In silenzio, la band lo segue dopo un momento di indecisione. Gli Who se ne vanno così, lasciando l’Odeon esterrefatto.
Ci vogliono 20 minuti per vederli rientrare, ma la band si è arresa e suona solo i vecchi successi. Townshend però è ancora imbufalito: fra un classico e l’altro del repertorio degli Who, mitraglia una raffica di insulti assortiti contro la platea, rea di non comprendere la sua ultima fatica, poi conclude lo show con una versione sismica di My Generation, con tanto di demolizione finale di un’altra malcapitata Les Paul e buttando a terra un Marshall, mentre – naturalmente – Moon sfascia il suo enorme drumkit e Daltrey si accanisce con il suo stivale da tamarro sul microfono. Poi lasciano il palco davvero, mandando affanculo l’Odeon che risponde estasiato con applausi scroscianti.
“Mod è vivere pulito in circostanze difficili...”
(Peter Meaden – The Who manager)
LIVE DIMENSION
Niente di nuovo, parrebbe. La formidabile reputazione live degli Who si è costruita impastando poderosi muri di violenza e watt [due settimane dopo, Townshend sarà addirittura costretto a chiedere al pubblico se vi fosse un bravo batterista per proseguire lo show, visto che il ‘farcitissimo’ Moon è collassato dopo esser andato di matto], ma questa volta è diverso. La frustrazione di Townshend è diversa. Dal febbraio 1974 al 1996, Quadrophenia non verrà più suonato dal vivo. Destino paradossale per l’opera più grande di Pete Townshend, eccezionale songwriter di fragorose melodie esplose a volume apocalittico dai suoi inconfondibili power chord. Dodici album di studio in quasi sessant’ anni di carriera con la band, ma ben otto nel periodo 1965-1978, quello in cui con Keith Moon in canna fanno a pezzi i palchi di mezzo mondo.
Gli Who non sono stati solo la prima, grande, rock band mondiale [considerando i coevi Beatles e Rolling Stones come band rispettivamente di pop e R&B] definendone lo status, ma anche un pezzo importante (oltre che la colonna sonora con lo strabordante inno My Generation) degli anni Sessanta della contestazione giovanile, urlata dai mega raduni oceanici di Monterey, Woodstock, Isle Of Wight: eventi resi immortali anche dalle stordenti performance della stessa band britannica. Perché dal vivo allora non ce n’è per nessuno. Gli Who sono stati la più grande live band della storia del rock, capaci di levare la terra da sotto i piedi persino ai Rolling Stones, che per invidia dell’esibizione degli Who non pubblicano il loro spettacolo “Rock n Roll Circus” registrato nel 1968... e che uscirà solo nel 1996.
La poderosa onda d’urto Who è catturata appieno dal monumentale Live At Leeds del 1970, che rivaleggia con Made In Japan dei Deep Purple come miglior live album rock di sempre.
E il capitano di quella ciurma pericolosa, Pete Townshend, oltre che portavoce generazionale e leader primigenio della sottocultura rock, è stato autentico pioniere della chitarra dura.
Musicista intuitivo e selvaggio dalle molteplici influenze (da Bo Diddley a Lennon, dalla musica classica di Wagner all’elettronica di Stockhausen o al minimalismo di Riley), Townshend è stato il primo, infatti, a portare il rock nel rock’n roll, a dirla con le recenti parole di Brian May: “il mio guitar-hero definitivo”.
Più interessato a scrivere melodie scatenate che ad esercitarsi a fare scale al fulmicotone, Pete ha esploso al meglio i migliori accordi di sempre del rock (l’irresistibile progressione A| G| D e le sue inversioni, i suoi micidiali hammer-on e pull-off). Il primo, autentico padrone del ritmo, con le sue sincopi adrenaliniche e l’ eccezionale timing, essenziale nel non fare deragliare una band che pone l’elemento solista proprio nelle furibonde digressioni (soprattutto live) della rivoluzionaria coppia Moon/Entwistle (batteria/basso, sezione poco ritmica ma pesantemente decorativa), scandito da quelle inconfondibili pennate secche ed energiche, mulinate furiosamente con il celebre gesto del Windmill, rubato ad uno svogliato Keith Richards dopo averlo visto iniziare così il suo soundcheck una sera del 1964, al Richmond Hotel.
Aggressivo e rumoroso come mai nessuno prima (e che evita agli Who quella vacuità che ad esempio hanno sul palco Cream o Zeppelin durante i gli assoli); archetipo del riff master hard/heavy come lo saranno poi Malcolm Young, Rudolph Schenker o Joey Ramone; trascinante con i suoi sferzanti power chord come punteggiature, gli accordi di quarta sospesi [in cui la terza di un accordo viene sostituita con un altro grado di scala, il suo vero marchio di fabbrica, ispirati alle sospensioni barocche del compositore del XVI secolo Henry Purcell] dirompenti anche con la seicorde acustica che Townshend rende protagonista nel rock con i suoi strambi accordi jazz o i celeberrimi, ampi e frenetici arpeggi, ritmati dalle sue mani grandi come vanghe, debitori della sua passione per il flamenco.
Il primo, Townshend, anche nel dare ai live una dimensione visiva teatrale, dove l’oltraggioso caos distruttivo diventa rito catartico collettivo, e dilatandone spaventosamente l’impatto sonico fino a usare i droni, costringendo le case produttrici a creare ampli sempre più mostruosi, cavalcandone i feedback, prima considerati orribili interferenze, ora ricercati e piegati alla sua inesauribile vena melodica, ispirando poi in tale direzione Hendrix.
Dietro quel decennio furioso di live dagli esagerati decibel da Guiness dei primati [che lo porterà progressivamente a perdere quasi l’udito], dietro chitarre sfasciate e feedback lancinanti, sforbiciate e mulinar di braccia, camere d’albergo devastate, contestatori e poliziotti scacciati dal palco a calci nel sedere, droga, alcol e party fuori dal mondo, c’è un artista completo e un uomo complesso.
Rude fino alla violenza ma disarmante nella sua dolcezza, in cerca di venire a patti con i suoi fantasmi ma sempre in empatia con i più giovani: mods, rockers, hippies che fossero, ne rappresentava e condivideva il disagio e il bisogno di spiritualità.
BACKGROUND
Peter Dennis Blandford Townshend, nasce in una famiglia di musicisti a Chiswick, West London, il 19 maggio 1945, primo di tre fratelli. Suo padre Cliff, ex-chitarrista, suona il sassofono contralto con la band di ballo della R.A.F, The Squadronaires, sua madre Betty Dennis è cantante professionista, mentre uno zio sviluppa pickup per Kalamazoo.
Hitler è morto da una ventina di giorni, l’Inghilterra è un cumulo di macerie fumanti ma è rimasta in piedi. Il matrimonio instabile dei genitori, alcolizzati, violenti e assenti (il padre in tour e la madre dietro i suoi vari amanti), l’affido dopo la loro separazione ad una nonna definita violenta e malata di mente, gli abusi subiti da un amico della stessa, il bullismo a scuola, imprimono a Pete cicatrici mai rimarginate che lo porteranno a combattere per una vita contro le droghe, l’alcol e la depressione. Pete cresce solitario e senza amici, rifugiandosi nei romanzi. Riunitosi due anni dopo con i genitori, tornati insieme, e trasferitisi tutti nella vicina Acton, Pete si avvicina alla musica.
I primi approcci sono proprio con il sax e con il pianoforte ma dopo aver visto il film “Rock Around The Clock” nel 1956 e, poco dopo i live di Johnnie Ray e Billy Haley a Londra, si arruola nel rock’n roll.
Inizialmente l’armonica cromatica per divertirsi, quindi una Hyra, una chitarra spagnola da 3 sterline, regalo di Natale da quella svitata di nonna Denny, a dodici anni. E’ il banjo la sua prima passione, strimpellato ascoltando i dischi di Acker Bilk, e che lui suona in un gruppo di jazz tradizionale, The Confederates.
Il gruppo comprende un altro ragazzaccio di Chiswick alla tromba, il suo unico amico John Entwistle, anche lui alla Acton County Grammar School prima di esserne espulso, e anche una testa calda poco più grande, Roger Daltrey, chitarrista della sua skiffle band, The Detours.
A fine 1961 Roger assolda John, passato al basso, e circa sei mesi dopo anche Pete sale a bordo, questa volta da solista; inizialmente con un ferro autocostruito con l’aggiunta del manico della sua Harmony acustica e qualche pickup, poi con una Epiphone Wilshire, la solid body elettrica acquistata a rate da Daltrey.
Sono due le scintille che forgiano nella sua testa la sua visione musicale: l’imbattersi nella potenza perturbante di Rumble di Link Wray e l’aver visto, a Londra, un diciottenne Clapton debuttare sul palco con gli Yardbirds e incendiare l’R&B.
I Detours si inseriscono nel circuito dei club e dei pub di West London e nel frattempo Pete studia da graphic design alla Ealing School of Art, dove amplia il delta-blues con l’arte radicale. Ribattezzatisi The Who e persi per strada cantante e batterista [con Daltrey che passa al microfono], la band è quasi pronta.
Per essere gli Who da 100 milioni di dischi venduti manca ancora l’agente del caos: Keith Moon. Ad aprile del 1963, dopo un’audizione impetuosa in cui si presenta con la sua aura di folle, zuppo d’alcol e con i capelli rossi, Moon ottiene il posto a patto che ripari il pedale della cassa che ha sfondato (insieme alle bacchette) nella foga della session.
Poco dopo, la band è convinta dal loro manager, il guru della sottocultura mod, Peter Meaden, a chiamarsi High Numbers e inserirsi in quel ribollente calderone nato a Shepherd Bush e fatto di parka e anfetamine, shopping stiloso a Carnaby Street e giri in Vespa a Brighton.
Ma la band ancora non decolla. Meaden viene mandato a spendere e due manager londinesi, Kit Lambert e Chris Stamp li ingaggiano, impressionati dai loro devastanti live. Tornati al nome The Who e adottato il celeberrimo logo che stilizza lo stemma della R.A.F. (quest’ultimo già simbolo dei mods), la band diventa l’emblema musicale del movimento.
In realtà, Moon adora il surf rock e Daltrey è un rude teddy boy, ma al tempo i mods riempiono le prime pagine dei giornali, allarmati dalle risse di massa che scatenano contro i rockers.
La fama di band di vandali-mods diventa leggenda quando nel giugno del 1964, durante un'esibizione al Railway Hotel, Townshend rompe accidentalmente la parte superiore della sua Rickenbacker a causa del soffitto basso. Infuriato per l’incidente e il disinteresse del pubblico, inizia a distruggere l'intera chitarra, scaraventandone i resti sulla platea. Il giorno dopo a Londra gli Who sono sulla bocca di tutti come la band che sfascia gli strumenti e l’atto iconoclasta [già punk prima della stagione hippie!] diventerà il pezzo irrinunciabile dei loro show, con sommo gaudio di quel matto di Moon che addirittura, nel 1967, concluderà l’esibizione di My Generation in tv, facendo esplodere la sua cassa imbottita di polvere da sparo... e provocando danni irreversibili all’udito di Townshend.
Il brusio arriva alle orecchie del produttore dei Kinks, l’americano Shel Talmy; Townshend scrive I Can't Explain, deliberatamente debitrice dei Kinks, per attirare la sua attenzione [sul lato B c’è Bald Headed Woman, con chitarra e fuzz di un giovanissimo Jimmy Page] poi Talmy vede il gruppo live e ne rimane colpito: gli Who sono una forza della natura. Pete, l’intellettuale nevrotico, che mulina frenetico il braccio destro sulla sua Rickenbacker e poi la sfascia contro il suo colossale Marshall-stack; Roger, il rissaiolo dai capelli d’oro e la voce di cuoio che rotea il filo del microfono come un lazo; Keith, il clown dinamitardo che suona agitando le mani per aria la sua batteria infinita, pestata e sfasciata con la ferocia e l’entusiasmo di un bimbo; infine Entwistle, il “bue” per imponenza e imperturbabilità, irremovibile sul suo agile e tonante Rickenbacker 4001S, mentre tutt’intorno è un pandemonio.
Messi sotto contratto con la sua casa di produzione, Talmy ne vende la registrazione al ramo statunitense della Decca Records, e nel gennaio del 1965 il successo repentino di I Can’t Explain (spinto dalla radio pirata Radio Caroline) certifica il decollo degli Who anche nelle UK Charts, là dove, a novembre, atterrerà al secondo posto l’inno My Generation, con il verso “I Hope I Die Before I Get Old” che sancirà l’identificazione del disagio di milioni di ragazzi incazzati nel rock duro... Hendrix, Pink Floyd, Zeppelin, Doors, Woodstock, arriveranno dopo.
1965-1969
Il 3 dicembre 1965 esce l’album di debutto My Generation, con l’inno Mod The Kids Are Alright: la Swinging London è fulminata dalla loro miscela fracassona di beat, soul, psichedelia, music hall, R&B e hard rock... prima che di hard rock si cominciasse a parlare. Ma gli Who non hanno ancora trovato la loro dimensione.
Nonostante si sia ormai rivelato come un juke-box continuo di hit (la rumorista Anyway, Anyhow, Anywhere, il pop’n’roll di Substitute, la lisergia ruvida di Magic Bus) la mente fervida e turbata di Townshend aspira ad altro che singoli perfetti di tre minuti. L’idea di salire di livello, musicando una storia compiuta comincia a farsi largo, supportata dagli input del suo mentore Lambert, appassionato di opera e conscio del potenziale artistico di Townshend.
L’ascolto di Wagner, Coricelli, Purcell, ne ampliano la visuale creativa.
La prima, distopica, narrazione, Quads, fallisce trovando comunque sintesi nel singolo di successo I’m A Boy, mentre l’interesse di Pete per pazzi e disadattati partorisce l’altra hit, Happy Jack. Lambert è lì che incita il suo pupillo ad andare oltre: “Quick, Quick!” Bisogna fare presto perché l’evoluzione impressa al pop dai Beatles è frenetica.
Nasce così A Real Quick One, mini-opera di 9 minuti contenuta nel secondo album A Quick One del 1966. L’idea del concept, qui in forma di pop art, torna anche l’anno dopo nel successivo The Who Sell Out (1967) che Townshend considera il primo, vero album degli Who. Strutturato come il programma di una radio pirata, con tanto di inserti pubblicitari fra un pezzo e l’altro, al suo interno spiccano i sei minuti della mini-suite Rael. È l’ultimo disco pop di un quartetto che poco dopo inizierà ad ingigantire sound ed ambizioni; anche perché il fenomeno mod è ai titoli di coda: Hendrix ha conquistato Londra (e Pete lo farà firmare per la loro nuova label Track Records), i Beatles dilatano le potenzialità dei 33 giri con Sgt Peppers, e la Summer Of Love è esplosa anche in Europa proiettando il rock in una nuova dimensione.
Gli Who, inoltre, sono praticamente al verde, visto che sfasciare ogni sera strumenti e camere d’albergo costa... nonostante poi Daltrey ripari i cocci delle Gibson di Pete.
TOMMY
Bisogna reinventarsi. Townshend si avvicina così all’olismo spirituale del guru indiano Meher Baba e, soprattutto, riesce finalmente, nel 1969, a mettere a fuoco la sua creatività, salvando la band con l’incredibile doppio Tommy: il concept album per antonomasia.
Non importa che i Pretty Things li abbiano preceduti con l’acida surrealtà S.F. Sorrow (che Pete ascolta per quattro giorni di fila!): da quel momento gli Who diventano sinonimo di opera rock creando uno degli album più (e peggio) copiati della storia (e ispirando addirittura una trasposizione cinematografica nel 1975). Sperimentando per la prima volta con i sintetizzatori VCS3 e ARP, Townshend affastella parecchi temi autobiografici ricorrenti nella sua poetica: i traumi infantili, il bullismo, la pedofilia, le sperimentazioni con le droghe, la ricerca di una guida spirituale. Con Tommy gli Who trovano la loro credibilità, diventando una band che fa ormai storia a sé. E che esplode letteralmente come una supernova.
Townshend amplia la sua espressività raddoppiando i suoi pirotecnici power chord con l’acustica; Daltrey trova definitivamente il suo ruggito, diventando uno dei migliori cantanti rock della storia; il mitico Frankestein di John Entwistle (un Fender Precision Sunburst del ‘65, così soprannominato perché assemblato con svariati pezzi di bassi precedentemente sfasciati) rimbomba enorme come un’orchestra, mentre Moon, senza essere quella macchina di precisione come lo è Bonham, diventa il cuore matto di un gruppo che, grazie alla dimensione live di Tommy, sta incendiando il mondo.
I celebri accordi di apertura di Pinball Wizard diventano il manifesto del chitarrismo trascinante di Townshend, esemplificazione del fascino di Pete per lo spostamento delle forme della triade (come l'accordo di Re) lungo il manico e l'uso delle corde più basse come droni. La coda di We’re Not Gonna Take It, poi, è l’archetipo del rock anthem, anticipata da quell’intenso e diafano See Me, Feel Me. Il clamore suscitato è tale che la band ne è quasi risucchiata: il mondo vuole subito un altro Tommy.
WHO’S NEXT
In quei mesi concitati, la creatività di Townshend riesce a ideare l’audace progetto multimediale Lifehouse, distopia fantascientifica retaggio del futurismo incrociato all’Art College e profezia di una società alienata da internet e dal lockdown, così avventato da lasciare perplessi i suoi stessi compari e il fido mago della consolle Glyn Johns. In pieno esaurimento nervoso, Townshend abbandona il progetto.
Ma le idee migliori verranno assemblate in quella collana di perle che è Who’s Next del 1971, dove trova posto la ballata rock definitiva, Behind Blue Eyes, e dove il Signore del feedback Townshend accoppierà i suoi dirompenti accordi maggiori con l’elettronica: dall’effetto marimba-repeat del suo organo Lowrey Berkshire che illumina l’immensa Baba O’Riley (ennesimo inno generazionale: liriche ispirate alla spiritualità del guru Baba e musica debitrice del minimalismo del compositore Riley) al pionieristico tappeto synth sul ruggente boogie di Won’t Get Fooled Again.
Dopo aver portato nel mainstream a volumi oltraggiose hits beat, l’opera e l’elettronica, Townshend vuole ancora nuove sfide. Ma nel 1972 la band è ferma. Daltrey scopre che Stamp e Lambert si pagano l’eroina con i soldi della band e, come Pete e John, pubblica un lavoro solista, mentre Keith si dà al cinema. Townshend non ha le idee chiare sulla strada da prendere ma da Tommy si può andare solo oltre e i trent’anni (età inaccettabile per chi cantava di sperare di morire prima di diventar vecchio) sono dannatamente vicini.
QUADROPHENIA
Da questo mix di ambizione e nostalgia (e dopo due concept cestinati rapidamente) nasce il portentoso impianto narrativo di Quadrophenia, l’obelisco degli Who.
Quadrophenia è interamente partorito dalla fertile immaginazione di Townshend, che a fine ‘72 si sblocca ricordandosi di una notte epica e struggente in spiaggia a Brighton dopo uno show degli High Numbers, quando era un mod diciannovenne, e scrive, arrangia e registra i demo completi di quasi cinquanta pezzi per quello che dovrebbe essere un album quadruplo (alla fine si ridurrà ad un doppio con 17 pezzi). Se Tommy è un’opera rock scritta su una chitarra classica, mistica e con squarci di flashback allusivi all’infanzia travagliata di Pete, Quadrophenia è ancora più cinematografico (e ne verrà tratto l’omonimo film nel 1979) aprendosi all’attualità e alzando il livello artistico, esecutivo e tecnologico come mai più dopo.
Più sinfonico, neoclassico negli arrangiamenti dei fiati di Entwistle e degli archi sintetizzati dell’ARP 2500 di Townshend (...ma il violoncello è suonato davvero da Pete) ma, al contempo, più chitarristico, quasi prog nelle cangianti stratificazioni, Quadrophenia (debitore dell’opera Billy Budd del compositore Benjamin Britten), è il passaggio traumatico all’età adulta e la fine dei sogni giovanili ad essere narrato, seguendo la storia dello squinternato mod Jimmy (ispirato alla reale figura del mod Irish Jack, irriducibile fan degli High Numbers), della sua drammatica presa di coscienza che quell’ideale di vita ribelle e modaiolo è stato seppellito dal tempo.
Il titolo, Quadrophenia, è un gioco di parole che riassume l’aspirazione di Pete, pioniere del dolby, di mixare l’album in Quadrifonia con la Schizofrenia per cui è in cura Jimmy, le cui personalità conflittuali sono allusioni a quelle caratterizzanti i singoli membri della band e associate da Townshend ad un motivo musicale che torna come un’epifania all’interno delle varie canzoni: A Tough Guy/ Helpless Dancer (Daltrey); A romantic/ Is it me? (Entwistle); A bloody lunatic/Bell Boy (Moon); A beggar, a hypocrite/ Love, Reign O’Er Me, (Townshend). [Il rude Roger, il romantico John, il lunatico Keith, l’ipocrita Pete: tutti simbolicamente rappresentati da Jimmy]
Le ambizioni del progetto si incagliano nel livello ancora pionieristico della tecnologia del tempo. Pete molla l’idea della quadrifonia e la band usa il furgone-studio-mobile prestato da Ronnie Lane (Small Faces) perché l’ex chiesa di Battersea adibita a studio, dopo cinque mesi, non ha ancora un mixer adeguato... in compenso, è colmo del numero esagerato di tamburi di Moon.
L’opera inizia in media res, aprendosi con il frastuono possente delle onde che s’infrangono sullo scoglio dove si è inerpicato il problematico Jimmy, espressione della gioventù proletaria londinese, tornato a Brighton a rivedere i luoghi simbolo del suo passato ruggente. Ma la delusione nel constatare che di esso nulla è rimasto e la coscienza del suo fallimento, lo porta a lambire l’idea del suicidio, affrontando il mare con una barca e arrampicandosi su quel faraglione. Da lì Jimmy si sfoga in una sorta di epica autoanalisi che termina con la sua redenzione (o maturazione) ma lasciando la storia senza un finale.
I Am The Sea è il medley introduttivo dei temi musicali che riaffioreranno poi carsicamente e che trova estensione nella titletrack, emozionante suite strumentale dove Townshend è dominante nell’alternare ispirati fraseggi a pomposi archi. Nel mezzo, la febbre di The Real Me, una delle canzoni più roboanti della band, con un Daltrey muscolare ed una sezione ritmica pazzesca con la quale Pete si incastra con un anfetaminico funky riff.
Mai come in Quadrophenia Pete si consacra maestro dei cambi repentini di mood: fra magniloquenza sinfonica e ballad asciutte, complessità prog e impatto hard rock, corni francesi e riff furibondi, inserti di pianoforte e break spaccamontagne, nichilismo punk e spiritualità gospel, ribellione proletaria e lirismo nostalgico, Quadrophenia culmina nella gigantesca preghiera Love Reign O’Er Me, l’apice espressivo di una band senza pari, con il Looove straziante di Daltrey che è anche il degno atto conclusivo delle session di registrazione, nell’agosto del 1973.
Quadrophenia è un kolossal dalla potenza espressiva che mozza il fiato e dall’intensità musicale che stordisce, capace, per le spiazzate critica e pubblico, di superare Tommy e di toccare la posizione numero due, sia in patria che in USA, nonostante la sua complessità e i molteplici piani di lettura... Fra i quali, anche quello di essere il nostalgico canto del cigno dell’ex band dei mods, che dalle cover R&B a Shepherd Bush è arrivata fino a Woodstock e che, nel 1978, con l’overdose di Moon morirà simbolicamente.
PETE TOWNSHEND – GEAR
All’inizio degli anni Sessanta, Townshend suona e distrugge le Rickenbacker (modelli 1997, 1998, 1993) e, dopo i flirt con Telecaster e Stratocaster, nel 1968 opta, in studio, per la Gibson J-200 acustica e la Gretsch 6120 Chet Atkins Hollow Body del 1959, con un amplificatore Fender 3x10” Bandmaster.
Dal vivo, invece, imbraccia Gibson SG Special fino al 1971, quando adotterà Les Paul Deluxe pesantemente modificate, dotate di un humbucker DiMarzio Dual Sound in posizione centrale, oltre ai mini-humbucker Gibson standard. Due ulteriori interruttori in stile pickup Gibson forniscono un coil-tap a due vie per il Dual Sound, l’altro un selettore a tre vie (Dual Sound on/off oppure tutti e tre i pickup attivati). Queste Deluxe in mogano/acero a tre pezzi non sono rinomate per il loro sound, ma la Les Paul di Pete ha ingrandito le cavità che ospitano il pickup e gli interruttori extra. Per la sua classica configurazione Les Paul Deluxe/Hiwatt Amp (fino al 1978), Pete utilizza un pedale Univox Super-Fuzz.
All’inizio degli anni Ottanta Pete usa chitarre Schecter Tele-style ma per un po’ i suoi problemi di udito lo costringono a suonare soltanto la chitarra acustica; poi passa alla Fender Stratocaster Eric Clapton. Come Dottor Jekyll e Mister Hyde, c’è un’enorme differenza tra il suono relativamente docile e pulito di Pete in studio e quello massiccio e distorto che ha raggiunto con i suoi muri di amplificatori a tutto gas sul palco.
Pete non registra con l’accoppiata Gibson/Hiwatt che usa invece sul palco; piuttosto, stratifica parti acustiche ed elettriche per creare dinamiche e tensione espressiva, ma nessun classico ha la potenza sfacciata delle versioni live.
Nei primissimi anni (1962-1965) Pete utilizza amplificatori Fender Bassman e Vox, prima che la sua continua ricerca di maggiore potenza e volume lo porti a Marshall, intorno al 1965, per avere un’arma sonora più potente ed essere sentito sopra la batteria pirotecnica di Moon.
Pete ha capito anche che è molto più facile ascoltarsi e controllare i feedback quando gli altoparlanti sono sollevati all’altezza delle orecchie e così richiede amplificatori da 100 watt con otto altoparlanti da 12” nello chassis: Marshall obietta che sono troppo pesanti da spostare, e infatti i roadie si rifiutano, ma poi Pete realizza che sono troppo difficili da distruggere alla fine degli show. Così lo chassis sarà tagliato a metà dando vita al Marshall Stack, ampli e cabinet separati, più facili da spostare e da rovesciare.
Sarà poi la volta della collaborazione di Pete con Dave Reeves, il costruttore di amplificatori che all’epoca lavora alla Sound City Amps. Reeves fonderà poi la Hiwatt che rifornirà Pete a dovere. Dalla metà del 1967 alla fine del 1968, Pete passerà agli amplificatori Sound City L100 da 100 watt, personalizzati per lui da Reeves, spacciandoli per Hiwatt e consigliandoli ad Hendrix.... Ma se Hiwatt è sinonimo del British rock sound, è principalmente perché Townshend è sinonimo di Hiwatt. Rispetto ai Marshall, i suoi amati Hiwatt Custom 100 sono follemente più rumorosi e significativamente più puliti ma, se tirati per il collo come fa Pete, offrono una distorsione liscia e calda, un sacco di crunch, un attacco esplosivo e un po’ più di suono di un vecchio Marshall. Il devastante “Live At Leeds” è rappresentativo del classico suono Hiwatt. Da Who Are You (1978) Pete si avvicinerà agli amplificatori Mesa/Boogie.
...................................................................................................
“Mia nonna mi ha comprato una chitarra quando avevo 12 anni ed era una chitarra molto, molto economica. Ho rotto le corde un sacco di volte e quando per sei mesi mi sono rimaste soltanto quelle del Re, Sol e Si, ho imparato un sacco di accordi. Quando ho avuto abbastanza soldi per comprare il resto delle corde, improvvisamente ho cominciato a suonare...”
“All’inizio mi sembrava folle anche solo pensare di competere con artisti del calibro di Beck, Clapton, Page e Blackmore... con quei dischi che ti lasciavano a bocca aperta. Ero molto frustrato perché non riuscivo a fare tutte quelle cose ispirate. Così ho iniziato ad esprimermi fisicamente... Dopo Hendrix, ho deciso che valeva la pena provarci, ma alla fine ho realizzato che la gioia di potermi esprimere attraverso un assolo non sarebbe stata mai così grande e così appagante come quella che provo nell’esprimermi attraverso una canzone...”
“C’è solo un accordo di cui non potrei fare a meno ed è il La [formato dalle note La, Do# e Mi] che si sente all’inizio di Won't Get Fooled Again. Suono tutte e sei le corde ma senza il Do#. Quell’accordo è in un certo senso la spina dorsale su cui poggia tutto quel che faccio...”
“All’inizio facevamo blues, avevo in testa cosa dovevo suonare, ma non riuscivo a esprimermi. Era frustrante. Cercavo di compensare le mie lacune di musicista con qualcosa di visivo e così facevo grandi movimenti solo per far sembrare un accordo più ficcante... Alzavo il braccio e lo facevo roteare prima di tornare sulla chitarra così che sembrasse una gran cosa, ma non lo era. Ho cominciato a fare salti sul palco, percuotere la chitarra, raschiarla contro il microfono e gettarla a terra alla fine dello show. Ho continuato a farlo e quando andavamo in una nuova città, la gente ci conosceva per queste cose. Un giorno qualcuno di un grosso quotidiano si era fatto avanti: ‘Ci dicono che spaccate le chitarre. Speriamo che lo facciate stasera, perché siamo del Daily Mail. Finirebbe in prima pagina...’ Sono andato dal mio manager Kit Lambert e gli ho chiesto se potessimo permetterci di distruggere due chitarre quella sera, per farci pubblicità. ‘Se è per il Daily Mail, vale la pena’, mi ha risposto. L’ho fatto e ovviamente il Daily Mail non ha comprato le foto e non ha proprio voluto saperne della storia. Ma a quel punto ci ero dentro e da allora lo facevo di continuo...”
“Le nostre sperimentazioni avevano a che fare con l’irritazione verso il pubblico che si lamentava se suonavi un brano rhythm and blues che non conoscevano. C’erano tizi con le loro pinte di birra che gridavano: ‘cos’è ‘sta spazzatura? Suona un po' di Shane Fenton!' Di rimando, diventavamo più rumorosi...”
Leggi anche
Podcast
Album del mese
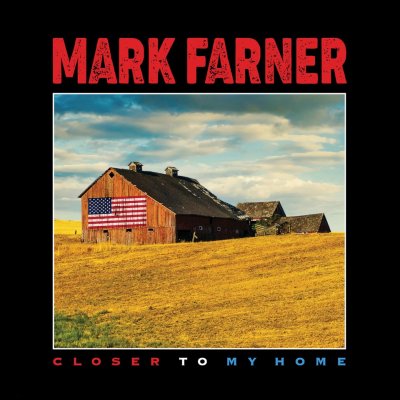
Mark Farner
Closer To My Home
Righteous Rock Records
Se tra gli scaffali di casa vostra campeggiano titoli quali On Time, Grand Funk o E Pluribus Funk potete tranquillamente continuare la lettura: avete tra...

Michael Kiwanuka
Small Changes
Polydor Records
Si parte con "Floating Parade" e si fluttua, tappa dopo tappa, tra la bellezza aerea di "One And Only", il progressivo incedere delle due parti...
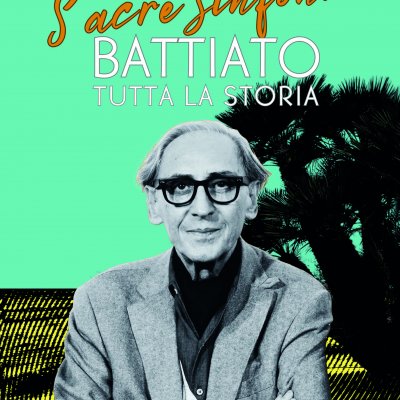
FABIO ZUFFANTI
Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia
Il Castello / Chinaski Edizioni
Nato dalla penna di Fabio Zuffanti, "Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia", è il titolo della più recente e completa biografia dedicata al celebre artista...






