Vita, opere e chitarre di RITCHIE BLACKMORE


1959. Cranford, area suburbana ad ovest di Londra. Un pomeriggio il giovanissimo sessionman James George Tomkins (non ancora entrato nella leggenda della chitarra rock inglese come Big Jim Sullivan) guardando severo il suo allievo, il quattordicenne vicino di casa Richard Hugh Blackmore, gli imprime queste parole nella mente: “Qualsiasi musica tu vada a suonare, le devi rimanere fedele. Trova la tua strada...” E quell’ossuto ragazzino, divenuto prepotentemente poi Ritchie Blackmore – il The Man In Black del rock duro – l’ha fatto diventare il suo mantra. Anche a costo di uccidere l’epopea dei Deep Purple, la superband da più di 100 milioni di copie vendute che, grazie alla sua Stratocaster, ha messo il turbo all’hard blues di Yardbirds e Cream trasformandolo nell’hard rock d’inizio anni Settanta, mollandoli quando sono sulla cima del mondo nel 1975...
l'articolo continua...
perché demotivato dalla loro svolta black; per risorgere come un’araba fenice negli imprescindibili Rainbow, il viatico definitivo all’heavy metal più epico degli anni Ottanta.
Certo, non ne gliene è fregato una mazza di stravolgerne la lineup ad ogni disco fino a scioglierli, resuscitare e mollare di nuovo i Deep Purple per poi scioccare il mondo mettendo definitivamente in soffitta le Fender e i Marshall, indossare calzamaglie come fosse a Sherwood nel 1500 e darsi alle ghironde e al folk celtico del progetto Blackmore’s Night con la terza moglie, la cantante e polistrumentista Candice Night, ex modella di 26 anni più giovane.
Tutto questo senza mai cedere ad un sorriso, avvolto nel nero perenne delle sue tutine e trafiggendo il mondo con il bianco delle sue occhiate: majors, pubblico, bandmate, promoter, giornalisti, tutti presi a turno a calci nel sedere (e spesso neanche metaforicamente) in più di sessant’anni di carriera spericolata ma devota alla sua musica; sempre in corsia di sorpasso col dito medio fuori dal finestrino, sulla strada tracciata da Hendrix... l’unico vero erede in un oceano di imitatori.
Quando, infatti, Jimi Hendrix a Woodstock scolpisce con i feedback più folgoranti le tavole del rock, Blackmore è il più lesto a recepirle andando ben oltre e definendo l’hard rock una volta per tutte. Anche con oltraggiose esibizioni live.
Se Hendrix ha sacrificato nel fuoco la sua Fender a Monterey, Blackmore l’ha usata come una clava contro una telecamera da 70mila dollari troppo impicciona, davanti ai 400mila tumultuosi del California Jam, per poi incendiare e far esplodere il suo Marshall lasciando un cratere sul palco e fare marameo alla polizia da sopra un elicottero, venuto precipitosamente a levare la band dai guai, con l’assegno da mezzo milione di dollari di cachet in tasca e sfangandola in uno style rock da spellarsi le mani.
Ma, soprattutto, se Jimi Hendrix è l’inventore della chitarra rock, Ritchie Blackmore lo è della chitarra solista.
Con lui gli assoli diventano autentiche canzoni nelle canzoni, capostipite degli atomici shredder degli anni Ottanta e autentico chitarrista dei chitarristi: da Brian May a Steve Vai, passando per Van Halen e Malmsteen, tutti ossequiosi dello sbalorditivo ecclettismo della sua tecnica e del suo tocco da Mandrake, capace di frullare, con un senso melodico sfacciato e ad un volume e un’aggressività inauditi, blues, R&R, jazz, country, glam, folk e classica, eliminando la distanza (e il complesso d’inferiorità) fra il rock e quest’ultima.
Eppure, pochi sono stati divisivi come lui. Perché Ritchie Blackmore è un arnese impossibile da maneggiare: lunatico e irascibile, egocentrico ed eccentrico, selvaggio e violento, intriso di un humour tetro con alcune passioni malsane come il Johnny Walker Black Label, gli strip-club e le sedute spiritiche. Lavorarci insieme significa finire al manicomio... chiedete al povero Roger Glover che una notte se lo vede irrompere nella sua camera sfondando la porta a colpi d’ascia modello Shining, solo per prendersi il crocefisso appeso alla parete, necessario per una sua evocazione.
Inoltre, ci sono quelle accuse di plagio, sulle quali da cinquant’anni ci ghigna sopra sarcastico... eppure, mai nessuno ha intentato causa contro i Deep Purple (come invece è successo ai Led Zeppelin).
Lo stesso Jon Lord [Deep Purple] ha sempre raccontato candidamente, ad esempio, che l’immortale Child On Time è nato improvvisando in sala prove sull’inizio di Bombay Calling degli It’s A Beautiful Day, mentre per Smoke On The Water, Blackmore ha sempre spiegato che è la Sinfonia N°5 di Beethoven invertita e interpetrata, prendendoci platealmente per il naso perché, in realtà, tanto sa di quella bossa nova di Carlinhos Lyra del 1964, Maria Moita.
Ma, onestamente, dal confronto con i due originali verrebbe da dire che, più che plagiare pezzi altrui, Blackmore abbia raccolto dei pezzi di vetro e li abbia trasformati in diamanti, come del resto agli albori dell’hard rock facevano tutti (Blackmore ha ammesso di aver cavato il riff di Black Night dal basso di Summertime Blues di Ricky Nelson, come dall’assolo della stessa Hendrix ha tratto l’inizio di Hey Joe) pescando magari fra gli standard del blues. E Blackmore, forse, allora pesca meglio di tutti. Picasso poi, ne era convinto: i mediocri copiano, i geni rubano!
E se non è un genio, Ritchie Blackmore è quantomeno un taumaturgo che ha reso immortali tutti i sodali ai quali ha appoggiato la sua Stratocaster. Come gli stessi Deep Purple, sotto la sua spinta trasformati da indefinita band pop-psichedelica à-la Vanilla Fudge, nella bestia hard rock più potente e pericolosa del pianeta Terra. O i grandiosi cantanti con i quali ha furbescamente duettato (e duellato..): Ian Gillan, David Coverdale, Glenn Hughes, R. J. Dio, per rimanere ai nomi più eclatanti, tutti proiettati nell’Olimpo del rock (e poi vaffa..) dalla sua chitarra tracotante.
EVOLUTION
Escludendo gli esordi di enfant-prodige, di sessionman e la svolta folk-celtica finale, l’evoluzione di questo stregone si può suddividere grossolanamente in tre periodi principali:
1) PISCHO-GARAGE
Dal 1968 al 1970, nei Deep Purple, Ritchie è molto fuzz-psichedelico-garage, soprattutto per certe dissonanze aspre e incisive. Gli assoli al fulmicotone delle cover (stravolte) Kentucky Woman e Wring That Neck (semplicemente, l’archetipo dello shredding), o il Tone vampirico di Mandrake Root sono plateali testimonianze dell’ecclettismo della sua calda e jazzy Gibson ES-335 Cherry del ‘61 (a metà degli anni Sessanta modificata con un ponte Bigsby-Vibrato e due humbucker PAF con poli regolabili per essere più versatile ed ottenere effetti più adatti al rock), pompata da un Vox AC30 e da un pedale Treble Booster, il celeberrimo John Hornby Skewes, con un potenziometro in più, come voleva lui.
2) IN ROCK
Con In Rock dei Deep Purple del 1970 c’è la svolta hard rock, con l’accoppiata Blackmore-Stratocaster che scrive la storia della musica dura. Famosa la smerlatura dei tasti (il segreto del suo inimitabile bending sbilenco, magistrale ad esempio su Highway Star), asimmetrica e graduale, che si accenta scendendo verso le corde più sottili, la soluzione originalissima ispiratagli strimpellando una chitarra acustica di seconda mano, comperata in Inghilterra con la tastiera estremamente consumata. Nota anche la sua avversione per il pickup centrale, tanto da farlo scollegare per poter essere più veloce.
In questo periodo avviene anche il passaggio ai Marshall Major da 200 watt modificati con due valvole extra integrate (ma i Vox AC30 rimarranno sempre i prediletti in studio e leggenda racconta anche sul palco, camuffati da Marshall…), bestie da 280 watt complessivi, presumibilmente gli amplificatori per chitarra più rumorosi mai realizzati, che lo certificano, con i 112 db registrati al Rainbow Theater di Londra del 1972, come il chitarrista allora più potente del pianeta.
È l’apice dei Deep Purple. Riff roventi alternati a paesaggi psichedelico-rumoristici hendrixiani s’innestano in veri fugati per violoncello. Blackmore diventa via via sempre più sontuosamente melodico, pulito, inserisce gli arpeggi, i fraseggi jazzy (l’assolo di Lazy rimane forse irraggiungibile) e quelli atonali con la "dissezione" dell'armonia e della melodia. L’uso (e abuso) spettacolare della leva, soprattutto live, si coniuga con il celeberrimo “effetto violoncello”, come nell’inquietante Fools. I lick di Ritchie spesso mescolano la scala blues con la dorica e la cromatica e, inoltre, probabilmente è il primo musicista rock a fare ampio uso della eolia.
3) BURN
Da Burn (Deep Purple, 1974) proprio le celebri lezioni di violoncello, prese in un momento di rigetto della chitarra, influenzeranno notevolmente il lo stile chitarristico di Blackmore. Sempre più post-hendrixiano e più orchestrale (e proprio l’assolo bruciante di Burn ne è un esempio), fino alla reincarnazione nei Rainbow, dove, abbandonato l’uso esclusivo della scala pentatonica blues, farà ampio uso del modo frigio che renderà il sound più cupo, orchestrale ed esotico con l'incorporazione sempre più marcata di soluzioni neoclassiche, mediorientali e medioevali, fino alla cosiddetta scala snake-charmer di Blackmore, una variazione della minore ungherese.
In questi anni, fra l’altro, Ritchie utilizza tantissimo la slide guitar, lo Schulte Compact phaser e il flanger. Nei Rainbow, persa la funzione ritmica dell’organo pesantemente distorto di Jon Lord, questi ultimi due effetti serviranno a rinvigorire nelle ritmiche la chitarra, spesso doppiata. Ma, soprattutto, Blackmore introduce l’AIWA TP1011 come preamplificatore. Il tape deck produce un boost di 3 watt, amplifica il segnale e manda in saturazione l'ampli e questo spiega il suo Tone sempre più terso ma con più sustain e gain, vera stella polare della sua ricerca sonora. In tal senso, Ritchie non è mai stato troppo soddisfatto né dei Major modificati e né dei successivi Super Lead (ecco, dunque, l’utilizzo anche del MTC), dei quali ama però la presenza scenica sul palco.
Blackmore perciò non è mai distorto più di tanto: è tirato, ma ogni nota si distingue nettamente ed è estremamente tagliente, dall’attacco immediato e pieno di dinamiche.
Alla fine dei Settanta, poi, la Strato Olympic White del 1974 con tastiera in palissandro diventa la sua chitarra principale più a lungo di qualsiasi altra.
RIFF & IMPRO
Blackmore è ovviamente sinonimo di riff (ma considera Greenleaves il più grande brano mai composto!) Ne ha prodotti a tonnellate, assassini e affilati, ma sempre con una punta di swing e di glam, spesso basati su due note sulla quarta. Da notare poi che il celeberrimo riff di Smoke On The Water è pizzicato, senza plettro e senza strappare power chords.
Eppure Blackmore è sempre annoiato dalla parte ritmica, non fondamentale data l’interazione con grandiosi tastieristi (necessaria anche per addensare il Tone sempre più nitido della sua Fender Stratocaster), per la quale si limita a suonare singole note che imitano la linea di basso e accompagnamenti sparsi basati su ottave. Ma, soprattutto, Blackmore conosce l’importanza della distanza fra le note, ciò che rende ariosa e maestosa la sua scrittura.
Certamente è più a suo agio come solista, dove il suo Staccato è forse il più riconoscibile fra i trucchi del suo cilindro. Ha la mano pesante, ma è anche capace di essere meravigliosamente delicato sia nell’uso dell’alternative picking, che nei legati e pull-off di corde aperte. Ritchie è anche uno dei primi musicisti ad utilizzare lo sweep picking, di solito sotto forma di arpeggi veloci, smorzati e rastrellati, e con una discreta quantità di fingerpicking con il pollice e l’indice.
Quel che più sconcerta, però, è la sua abilità di improvvisare, anche per ovviare a una pessima memoria-tecnica, motivo per il quale non ha mai composto o memorizzato nessuno dei suoi assoli (eccezion fatta per il barocco supersonico di Highway Star e la sua fuga di semitoni). Ecco perché nessun brano o assolo dei Deep o dei Rainbow può essere mai sentito identico in sede live.
THE MAN IN BLACK
Di sicuro nascere durante la guerra, esattamente l’11 aprile del 1945 a Weston-super-Mare, vicino a Bristol (ma presto trasferitosi ad Helston, nei pressi dell’aeroporto di Heathrow), nell’Inghilterra ridotta in macerie e affamata, ne ha indurito la pellaccia, allisciata peraltro dal sistema educativo inglese, con le punizioni corporali a scuola e la rigidità da caserma a casa. È così che il tumultuoso Richard a sedici anni, stufo delle vergate, molla la scuola deciso a non diventare come i suoi prof e a far vedere loro che quello studente deficiente, in realtà sarebbe diventato qualcuno... magari come Tommy Steele, il primo teen idol della gioventù inglese, che lo fulmina quando lo vede in tv scatenarsi a ritmo di R&R, proprio quel sound frenetico che, a partire dal 1955, ha conosciuto dalle frequenze di Radio Luxembourg con Elvis, Billy Haley, Buddy Holly e Duane Eddy.
Da qui il desiderio di rompere quell’autoritarismo ottuso a colpi di chitarra che quel gallese tutto d’un pezzo di suo padre Lewis asseconda comprandogli, ad undici anni, una Framus nera ma ponendo la condizione di prendere lezioni di chitarra classica: “Impara quest’aggeggio come si deve, o te lo spacco in testa!” Ritchie lo farà, sciroppandosi in bici 10 km fra andata e ritorno e acquisendo rigore sullo strumento.
Blackmore ama Les Paul, Django Reinhardt, Wes Montgomery, James Burton, Scotty Moore, Jimmy Briant, la pedal steel di Speedy West ma anche Lonnie Donegan, e le prime esperienze sono proprio in una skiffle band suonando una dog box. Poi arrivano le lezioni di Big Jim Sullivan che gli insegnerà ad usare il mignolo e ad essere uguale a nessuno; lo shock per la Hall Of The Mountain King dei Nero & Gladiators; la sua prima elettrica, una Hofner 50, comprata con i soldi guadagnati lavorando al vicino aeroporto di Heathrow smanettando trasmettitori radio, una volta mollata la scuola.
E a sedici anni, quel ragazzino secco come un chiodo che sembra il sosia di Mr Bean, si fionda nella swinging London e debutta con un singolo per la Decca Records con i Mike Dee & The Jaywalkers. Poi seguiranno i bizzarri Screaming Lord Sutch & The Savages (dai quali apprenderà i trucchi del perfetto showman) e i promettenti Outlaws con i quali sarà band di supporto di Jerry Lee Lewis e Gene Vincent. (Il loro singolo Shake With Me è testimonianza sbalorditiva di come diavolo suoni già l’allora minorenne Blackmore a metà dei Sessanta).
La sua è già una vita da randagio del rock n’roll alla ricerca del treno giusto sul quale saltare, fra Londra, dove è sessionman per il produttore John Meek, ed Amburgo, dove è di casa allo Star Club, il locale degli esordi dei Beatles. Ci scappa anche una puntata italiana, nei The Trip, con i quali farà da backing band del Camaleonte Riki Maiocchi. Ma è la chiamata, a fine 1967, del batterista Chris Curtis che cambia il suo destino: non per il suo strampalato progetto Roundabout, affondato subito dagli abusi di LSD dello stesso Curtis, ma perché Blackmore conosce il suo coinquilino, l’immenso Jon Lord, il profeta dell’Hammond, l’unica persona della quale si fiderà nella sua vita.
Sbarazzatisi dell’inconcludente Curtis i due completano la formazione aggiungendo al bassista Nick Simper il frontman Rod Evans e, soprattutto, Ian Peace alle pelli, ex violinista dallo swing jazz. Blackmore cestina il vecchio nome Roundabout sostituendolo con il titolo di una canzone di Peter Derose tanto amata da sua nonna: Deep Purple.
DEEP PURPLE
L’11 e il 12 maggio del 1968, i Deep Purple registrano il loro debutto, Shades Of Purple: la band graffia ma non ruggisce. La cosiddetta Mark I (la loro prima lineup) rilascia nei successivi undici mesi tre dischi interessanti fra psichedelia e pop, R&R e classica ma non fa il botto e, soprattutto, Blackmore morde il freno. Ha visto a Birmingham i Led Zeppelin che gli hanno scompigliato la chioma ed ha capito che là fuori si sta preparando una colossale tempesta metallica. Inoltre, l’uragano Hendrix ha dimostrato la potenza dirompente dell'unione Strato più tremolo e Ritchie vuole sfruttarne tutte le potenzialità.
Così nel 1968, mentre i Deep Purple sono in tour negli Stati Uniti come band di apertura per i Cream, Blackmore compera da un roadie, per 60£, una Stratocaster che Clapton gli ha regalato (malconcia ma con la quale registrerà il brano Emmaretta). È subito amore, così nel 1969, acquista una Stratocaster standard con manico in acero e ponte tremolo. Da lì ne userà una ventina: nere, bianche o sunburst, con tastiere in palissandro, palettone vintage, manici smerlati e single coil di bordo.
Nick Simper e Rod Evans lasciano quindi spazio a due calibri più pesanti, Roger Glover e Ian Gillan, ed ecco allora la celeberrima Mark II, la formazione di virtuosi teppisti che imprimerà i propri nomi nel monte Rushmore del rock.
Ma prima c’è ancora l’ambiziosissimo Concerto For Group And Orchestra, con la Royal Philarmonic Orchestra: Blackmore è stratosferico (... da arresto nel First Movement!) ma anche stufo marcio e all’amico Lord la mette così: “Facciamo un disco veramente rock e se va male torniamo a fare musica classica...” Jon acconsente e Ritchie prende in mano il comando delle operazioni.
Lord crea il suo beast-sound collegando l’Hammond C3 nel Marshall, Blackmore inaugura la Stratocaster (ma il monolite Child In Time è registrato ancora con la Gibson) e l’utilizzo incendiario della leva del vibrato (ispirato dopo aver visto la James Cotton Blues Band al Fillmore East) e il mondo verrà spazzato via dallo spostamento d’aria di In Rock, 1970. Incollato a meraviglia alla “bestia” di Lord, Blackmore mescola Bach e Hendrix (nell’indemoniato Hard Lovin Man, sbatacchia forsennatamente la Stratocaster contro la porta dello studio fra lo sconcerto dei tecnici) con un Tone che è una lama arroventata, oltraggiando e rinnovando l’eredità blues nel R&R.
Alla pesantezza dei Black Sabbath e al groove dei Led Zeppelin, i Deep Purple aggiungono la velocità ma distinguendosi per un approccio blues più progressive, in bilico fra rumorismo e barocco, come l’indemoniato R&R di Speed King compendia. È la ricetta magica con la quale la band sfornerà nello spazio di un solo biennio (intervallati dall’ottimo Fireball, 1971), altri due dischi decisivi nel fissare l’hard rock nella cultura popolare: Machine Head (1972) e Made In Japan (1972), ovvero, l’album con il rock riff più celebre di sempre (Smoke On The Water, naturalmente), nonché il live album più grande di sempre.
Made In Japan è la fotografia di una band per alcuni aspetti insuperabile e del magico approccio live di Blackmore, impeccabile e assolutamente imprevedibile (in realtà, è una pezza per la band così dilaniata che in sei mesi ha registrato solo un pezzo nuovo, Woman From Tokyo): un riempitivo estemporaneo, inaspettatamente diventato un disco epocale.
Ma è anche l’apice a cui segue un rapido declino. Spremuti come limoni nella folle catena di montaggio disco-tour (infiniti)-disco che costringe troppi galli a stare troppo tempo rinchiusi insieme, la formazione Mark II naufraga fra faide e risse: prima Gillan molla il colpo esasperato da Blackmore (i due viaggiano, alloggiano e registrano separatamente!), poi Glover è messo alla porta dal Man In Black; infine, lo stesso Blackmore scende dalla carrozza, stanco di quella band che ormai non controlla più e che la scintillante coppia Hughes-Coverdale sta traghettando verso quella musica da lustrascarpe, come sprezzante definisce la deriva funky-soul di Stormbringer (1974). I Deep Purple non sono più quella band sfrontata ma solo una gigantesca macchina da soldi.
RAINBOW
Cooptato il carismatico Ronnie James Dio, cantante dai polmoni di cuoio che lo ha impressionato con i suoi Elf nel momento in cui aprono per i Deep Purple nell’ultimo tour statunitense, nel dicembre del 1974 Ritchie registra Black Shape Of Family, la cover dei Quatermass che nessuno dei Purple aveva voluto fare. È la scintilla. Terminato il tour di Stormbringer, Blackmore saluta tutti.
A trent’anni, dopo tanti onori e record, Blackmore ha ancora molto da dire e con R.J. Dio (che pretende però di coinvolgere i suoi compari Elf) è pronto a dichiarare di nuovo guerra al mondo. I due battezzano la nuova band in onore al Rainbow Bar&Grill di Los Angeles (a un tiro di schioppo da dove vive Ritchie allora) dove si trovano sbronzi marci a discutere del nuovo progetto. Ritchie Blackmore’s Rainbow esce così nel maggio del 1975, concepito nella tana del Musicland di Moroder a Monaco, in Germania, e con la produzione del fido Martin Birch dei Purple. Ironicamente, l’Uomo In Nero risorge con il suo Arcobaleno, dove sfoga le intuizioni che nei Purple venivano ormai cestinate.
Il disco ottiene un discreto riscontro in UK e rivela la grandezza di R.J. Dio, i cui testi fantasy e l’interpretazione enfatica sono l’estensione perfetta delle atmosfere neoclassiche e tuonanti di Blackmore. L’epidermico riff glam rock di Man On The Silver Mountain, lo sliding sognante di Catch The Rainbow, la rilettura strabiliante di Still I’m Sad degli Yardbirds trasformata in una cavalcata epica, spiccano in un disco da stropicciarsi occhi e orecchi.
Ma è solo l’antipasto.
Blackmore ha ormai messo a fuoco il sound dei Rainbow e così azzera la lineup, mantenendo ovviamente l’intoccabile R.J. Dio, e toglie il suo nome dal monicker.
Trovato nel diamante-pazzo Jimmy Bain il bassista col phisique du role, le restanti audizioni, al Pirate Sound di Hollywood, sono condotte con crudeltà. I batteristi, ad esempio, si montano in solitudine l’attrezzatura in sala, mentre Ritchie e Jimmy giocano a biliardo dall’altra parte dell’edificio, poi entrato finalmente in studio, Blackmore s’attacca all’ampli e mitraglia un serratissimo dat-dat-dat-dat che, se per cinque minuti è grandioso, dopo venti minuti stroncherebbe anche Terminator. Poi i due satanassi mollano gli strumenti e tornano a giocare a biliardo senza mai aver aperto bocca, mentre il malcapitato di turno capisce l’antifona e raccoglie la propria roba mestamente.
È così per 14 volte. Poi arriva Cozy Powell, ulteriore purosangue indomito già con Jeff Beck e con un singolo psycho-rock in classifica, intitolato ironicamente Man In Black. Blackmore prova a schiantarlo con riff tritaossa per quaranta minuti, ma quel satanasso lo segue a ruota; Blackmore, allora, posa la Fender col ghigno di chi ha trovato l’uomo giusto quando Cozy, ancora sullo sgabello, con un tremendo doppio colpo di cassa, avverte i due banditi che lui, di cartucce, ne ha ancora.
La stessa strafottenza la mostrerà il ventenne tastierista Tony Carey, per nulla intimorito dallo stare di fronte al Supremo anzi, è pronto a replicare alle sue citazioni di Bach con lo stesso volume e guardandolo negli occhi: il posto non può non essere suo ma durerà soltanto un anno e Blackmore glielo renderà infernale.
Questa incredibile formazione di pirati entrerà nella storia del rock duro come una delle più carismatiche e talentuose di sempre grazie al seminale Rising.
Il 1976 non è solo punk. È anche l’anno che getta le fondamenta per il futuro heavy metal degli anni Ottanta per la contemporanea uscita di un tris di album innovativi e “progressivi”: 2112 dei Rush, Sad Wings Of Destiny dei Judas Priest e appunto Rising, siglato Rainbow. Partorito sempre al Musicland di Monaco e sempre con Birch alla consolle a scolpirne i muscoli, Rising è un disco enorme, l’ultimo grande album del classic hard rock dei Seventies e, contemporaneamente, il più grande disco heavy metal di sempre, secondo la prestigiosa rivista Kerrang.
Ancora più orchestrale e beethoveniano, epico e possente, immerso in un’atmosfera fantasy medievale e cosmica – che inaugura il fortunatissimo filone dungeons & dragons fatto poi dai vari Maiden e Manowar – Rising è l’album più ambizioso e personale di Blackmore, evoluzione pazzesca del sound dei Deep Purple, fra hard shuffle, triadi neoclassiche e slide guitar. Un kolossal racchiuso in soli sei brani e 33 minuti, con tre episodi a rappresentare la palla di vetro del metal futuro.
Tarot Woman si apre con l’assolo spaziale di mini-moog di Carey che dilata orizzonti sconfinati e desolati, là dove cavalca poderosa la Fender di Blackmore con in sella l’ugola nata dal tuono di R.J. Dio, menestrello d’acciaio dall’intensità leonina. Impressionante sentire il vibrato killer di Ritchie calato in un’ambientazione tolkieniana... Le altre due gemme, invece, compongono da sole il lato B.
Stargazer è il fulcro dell'album, un'epopea di otto minuti che combina assieme la passione di Blackmore per la musica classica con R.J. Dio, là dove quel biblico riff viene composto da Ritchie al violoncello, pur se il punto forte è il bruciante lavoro di sliding abbinato alle scale orientali. Aperto dalla celeberrima intro terremotante di Powell dietro i tamburi, il brano si snoda maestoso e cadenzato, ammaliante nella scala turca degli archi sintetizzati del Vako Orchestron, ed in più contiene il più bel assolo heavy metal che si ricordi, con un Blackmore che si spinge oltre quanto mai fatto prima: esotico e arcano, ipnotico come il volo notturno di un tappeto volante sopra un deserto. L’interpretazione di R.J. Dio, poi, è commovente, mistica, eroica, mentre Carey è così centrale e suggestivo che le malelingue sostengono che Blackmore non abbia mai voluto suonarlo dal vivo per invidia nei suoi confronti. Se non bastasse, la coda finale vede anche l’intervento della Orchestra Filarmonica di Monaco, a rendere il tutto ancora più regale. Stargazer è l’allineamento magico e irripetibile degli astri della band, ognuno capace di sfoggiare una performance che rimarrà probabilmente la più alta della propria carriera.
La saga del Mago egizio appena narrata si conclude nei successivi otto minuti di Light In The Black, un treno lanciato a folle velocità da quella testa calda di Cozy, manifesto del futuro power metal di Queensryche, Savatage, Helloween, e una ulteriore esibizione di supremazia sonica con gli assoli chilometrici di Carey e Blackmore che si inseguono e si sfidano esaltanti. Il boato intorno all’album lo renderà disco d’oro in Inghilterra.
VERSO NUOVI LIDI
Purtroppo, l’ego di Blackmore manderà presto al diavolo Bain e Carey e, dopo l’eccezionale Long Live Rock n’Roll, anche Dio prenderà la porta, stufo delle fantasie castle-metal di Ritchie e in cerca di un taglio più AOR. Dio si rifarà con l’accoppiata storica Heaven And Hell (con i Black Sabbath) e Holy Diver (da solista) che lo eleggerà patriarca dei cantanti metal, mentre Ritchie autodistruggerà lentamente li suoi Rainbow consegnandoli, e consegnando lui stesso, definitivamente al mito. Dopodiché partirà con l’avventura Blackmore’s Night, alla conquista della musica celtica e di mondi sonori lontani nel tempo.
Leggi anche
Podcast
Album del mese
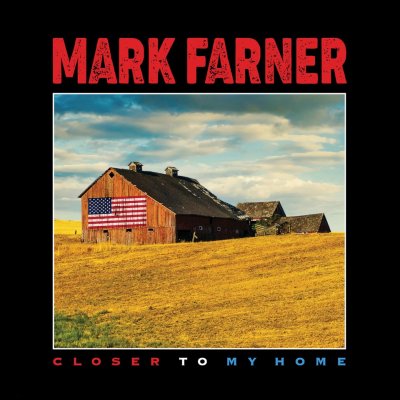
Mark Farner
Closer To My Home
Righteous Rock Records
Se tra gli scaffali di casa vostra campeggiano titoli quali On Time, Grand Funk o E Pluribus Funk potete tranquillamente continuare la lettura: avete tra...

Michael Kiwanuka
Small Changes
Polydor Records
Si parte con "Floating Parade" e si fluttua, tappa dopo tappa, tra la bellezza aerea di "One And Only", il progressivo incedere delle due parti...
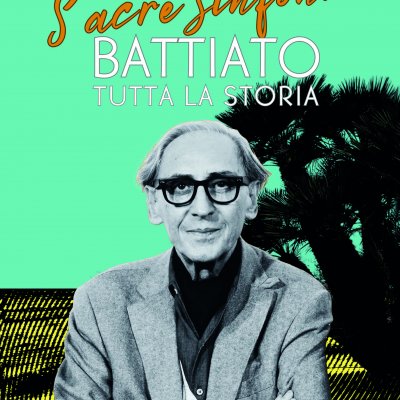
FABIO ZUFFANTI
Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia
Il Castello / Chinaski Edizioni
Nato dalla penna di Fabio Zuffanti, "Sacre Sinfonie, Battiato: tutta la storia", è il titolo della più recente e completa biografia dedicata al celebre artista...




